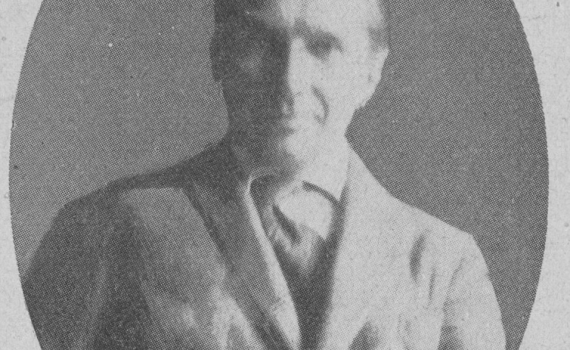
Perché non c’è ancora nessuna prima mondiale in scena?
Category : spettacoli | Auff it
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Dahms
Hamburg Staatsbibliothek https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN774616555_0016
[pgc_simply_gallery id=”221″]
Walter Dahms scrisse un articolo dettagliato sull’opera nel 1912.
Il motivo per cui non è ancora prevista una rappresentazione completa (siamo ancora nel 2026!) è descritto qui:
Quando ho preso in mano per la prima volta la riduzione per pianoforte di “Sarastro” di Goepfart, sono rimasto scioccato dall’audacia del suo autore nel proporre ai nostri tempi qualcosa di così incredibilmente semplice, chiaro e inequivocabile. È vero, quest’opera fu concepita e creata per l’anniversario di Mozart nel 1891. Ma le più sfortunate turbolenze (soprattutto il grande sciopero dei tipografi) ne impedirono l’esecuzione prevista – a Dresda e Praga – in quel momento. Poi, l’anno successivo, era già troppo tardi. Quindi “Sarastro” giace ancora ineseguito [ nota dell’autore: 1912]. Se dipendesse dai buoni tedeschi, così poco informati sui loro artisti dai loro giornali preferiti , l’opera potrebbe rimanere ineseguita fino alla fine dei tempi . Ma sarebbe deplorevole se il muro di inerzia e malizia che un giornalismo altamente unilaterale e interessato ha eretto tra le menti creative e il pubblico credulone non potesse essere infranto a un certo punto. Il tentativo sarebbe utile, istruttivo e promettente.
Dramma musicale “Sarastro” di Karl Goepfart
Di Walter Dahms
Chi di questi tempi non drizza le orecchie quando sente parlare di un’opera intitolata “Il flauto magico, parte seconda”? Si parla e si scrive tanto di Mozart come del salvatore dalla crisi musicale odierna, come della guida che emerge dal deserto dell’improduttività moderna. “Torniamo a Mozart!” gridava la gente. Weingartner diceva: “No, avanti con Mozart!”. Qualunque sia l’interpretazione, una cosa è certa: un ulteriore sviluppo dell’arte musicale e drammatica non può mai essere un “andare oltre Wagner”, ma che il compositore teatrale che voglia creare qualcosa di raro, duraturo e anche nuovo deve partire da un punto precedente a Wagner. Perché ci sono ancora molte strade inesplorate che conducono alla meta di un’arte grande e sublime.
Quando ho preso in mano per la prima volta la partitura per pianoforte di “Sarastro” di Goepfart, sono rimasto scioccato dall’audacia del compositore nel offrire ai nostri tempi qualcosa di così incredibilmente semplice, chiaro e inequivocabile. È vero, quest’opera fu concepita e creata per l’anniversario di Mozart nel 1891. Ma le più sfortunate turbolenze (soprattutto il grande sciopero dei tipografi) ne impedirono l’esecuzione prevista – a Dresda e Praga – in quel momento. Poi, l’anno successivo, era già troppo tardi. Così, “Sarastro” rimane ancora ineseguito. Se dipendesse dai buoni tedeschi, così male informati sui loro artisti dai loro giornali preferiti, l’opera potrebbe rimanere ineseguita per sempre. Ma sarebbe un peccato se il muro di inerzia e malizia che un giornalismo fortemente unilaterale e interessato ha eretto tra gli artisti e il pubblico credulone non potesse essere superato a un certo punto. Il tentativo sarebbe utile, istruttivo e promettente allo stesso tempo.
“Sarastro” mi ha lasciato un’impressione profonda e duratura fin dal primo ascolto. Ho continuato ad ascoltarlo più e più volte. Il mio interesse è cresciuto costantemente. Ecco, finalmente, un’opera che mirava a qualcosa di completamente diverso da ciò che è amato e incoraggiato dai tempi moderni. Qui, le nostre emozioni umane primordiali non sono destinate a essere disgustate (come nel caso dei veristi popolari e dei loro seguaci tedeschi) – no, qui sono destinate a essere raffinate. Qualcosa di puro, concreto, sano – in breve, qualcosa di tedesco ci parla qui con una beatitudine potente, sentimentale e lacrimosa, come sfoghi patologici, sia verbali che musicali. Pertanto, ora scrivo una parola di avvertimento per quest’opera, perché ho maturato la ferma e incrollabile convinzione, come musicista e critico, che debba avere un effetto anche su ogni altra persona ricettiva a ciò che è nobile.
Tutto è simbolico: la lotta tra luce e tenebre, tra bene e male. Anche il “Flauto Magico” di Mozart aveva questa tendenza. Era una protesta, comprensibile per gli esperti della Vienna di allora, contro l’inerzia, contro la depravazione e l’oppressione della coscienza in ogni ambito . Senza alcuna fantasiosità umanitaria, cercava di proclamare l’ideale della fratellanza umana universale. (Tuttavia, la Rivoluzione Francese, che era dietro l’angolo, impose una stridente dissonanza a questo ideale – anche una sorta di fratellanza, ma diversa!). A quel tempo, l’obiettivo era quello di rappresentare personaggi purificati dalle prove del destino. Fuoco e acqua erano solo simboli. La lotta tra luce e tenebre, tra Sarastro e la Regina della Notte, non è rappresentata ne “Il Flauto Magico”, tuttavia. Il finale indica i tempi a venire, un’epoca di lotte e conflitti.
Niente meno che Goethe progettò e abbozzò una seconda parte del Flauto Magico, il dramma di Sarastro, come testo operistico. L’opera di Goepfart, il cui poema fu scritto da Gottfried Stommel, poggia su questo fondamento. La continuazione del Flauto Magico da parte di Goethe era giustificata. La lotta tra le due forze elementari opposte, simboleggiata approssimativamente dalla luce e dall’oscurità, doveva essere risolta a un certo punto. La bozza di Goethe fornì le linee guida drammatiche per Goepfart e Stommel. La musica di Mozart doveva essere mantenuta in alcune melodie e motivi in alcuni punti. E l’esito doveva essere conciliante: l’amore doveva superare l’odio. Altrettanto necessaria era l’attuazione delle idee massoniche attraverso il conflitto voluto da Goethe. Non vi può essere dubbio sulla giustificazione della continuazione del Flauto Magico da parte di Goethe; lo si affermerà incondizionatamente e con gioia quando si sarà assistito al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso l’esecuzione impeccabile dell’opera Goepfart-Stommel.
Una riflessione su “Sarastro” rivela che gli atti, nella loro struttura, portano con sé un elemento distintivo della loro essenza . Il primo atto contiene l’esposizione. Ci introduce ai vari mondi del dramma: quello del bene (Sarastro), quello del male (Regina della Notte) e quello dell’umanità primitiva (Papageno). Dopo le solenni note introduttive dell’ouverture del Flauto Magico , il sipario si alza sull’assemblea dei sacerdoti. Ogni anno inviano uno dei loro fratelli nel mondo per testimoniare la sofferenza e la gioia dell’umanità. Il pellegrino terreno è tornato puro, e questa volta il suo destino tocca a Sarastro, il loro capo in persona. Riconosce in questo un’allusione speciale: “La divinità mette alla prova nel pericolo!”. Sa che lo attende una grave, grande missione. L’antica nemica, la Regina della Notte, il male primordiale, deve essere sconfitta. Solo lui è in grado di farlo; poiché attraverso la sua superiore cultura spirituale, lui vede attraverso le sue intenzioni, ma lei non le sue. Un tono solenne e serio pervade l’intera scena. Ritmi sostenuti, armonie chiare e melodie profondamente toccanti permeano la musica. È già chiaro: “Sarastro” è un’opera vocale nello stesso senso delle opere di Mozart. Da qui deriva anche la posizione speciale dell’opera nella letteratura operistica moderna. L’orchestra non ha voce in capitolo; fornisce solo l’ambiente, il terreno, per così dire, su cui si svolgono gli eventi (di natura musicale).
La prima trasformazione ci porta nel regno della Regina della Notte. Una rappresentazione del personaggio di tipo contrastante. I ritmi vivaci trasmettono immediatamente un senso della meschina inquietudine che regna in questo regno. Come Sarastro, la Regina ci viene mostrata in mezzo ai suoi compagni d’armi. Monostatos, il Moro, la cui figlia Pamina è fuggita ne Il Flauto Magico e che ora serve e ama la madre, riferisce alla Regina che l’opera di vendetta contro il Regno della Luce è in pieno svolgimento. Il figlio di Tamino e Pamina, il figlio del re, giace rinchiuso in una bara d’oro, il cui coperchio solo il loro potere oscuro può aprire. Simbolicamente: la nuova era è schiavizzata dagli spiriti timorosi della luce. Gli ululati trionfali della Regina rivelano la sua opposizione interiore al nobile Sarastro. Quanto è giusta la sua lotta contro di lei!
La seconda metamorfosi mostra Tamino e Pamina in preda alla preoccupazione genitoriale per il loro tesoro. I crescenti timori di Tamino per il figlio lo portano a ricadere nella sfera d’influenza della madre, la Regina della Notte, che cerca di persuaderlo a vendicarsi di Sarastro. Ma questo si rivela una tentazione per Sarastro, che lo consola con la promessa di una grande missione futura per il bambino. Dal tenero lirismo del coro femminile, il cui canto accompagna l’incessante trasporto della bara, la musica nella scena della tentazione si sviluppa con forza e conduce al magnifico, primordiale coro sacerdotale “Chi si opporrà alla luce?”
La terza metamorfosi ci presenta la vita e le attività del popolo naturale, disinibito, incarnato da Papageno e Papagena. Qui, nell’allegro trambusto dei bambini, tra gioia e scherzi, avviene la nascita di Aurora, dono degli dei. È la figlia del popolo, destinata a redimere il figlio della casa principesca. Una musica di melodiosa serenità accompagna questa trasformazione. Appaiono diverse melodie mozartiane. Il flusso e il riflusso della vita fluiscono vividi, inesauribili e con colpi sicuri, tanto semplici quanto efficaci.
Mentre il primo atto forniva l’esposizione del dramma, il secondo raggiunge il culmine dell’effetto drammatico con l’esplosione delle forze ostili. Fedele alla sua vocazione divina, Sarastro è in viaggio sulla terra. Qui incontra il suo vecchio nemico. Il destino delle due forze elementari, luce e tenebra, si compie. La regina non riconosce il viandante. L’incantesimo dell’ignoto la travolge e la fa ardere di un amore ardente per lui. Cerca di conquistarlo per i propri fini, tutti volti alla distruzione di Sarastro. Alla fine, egli accetta di aiutarla a eliminare Sarastro quando lei giura di liberare Febo, figlio del re, dalla bara d’oro e riportarlo in vita. Sarastro si rende conto di dover fare sacrifici per sconfiggere la regina e inaugurare la “nuova era”. La forza etica della sua personalità e delle sue confessioni è meravigliosa. La musica di Goepfart è altrettanto riuscita quanto quella del poeta nel costruire ed eseguire questo atto magistrale. Attinge interamente al suo talento, e la sua fonte di inventiva melodica e caratteristica è inesauribile. Con tratti sintetici, trasmette contrasti. Il suo linguaggio musicale è drammaticamente potente e inquietante, eppure del tutto unico e nuovo. La sua sicurezza nell’esprimere le emozioni è evidente ovunque. Significativo è il modo in cui la Regina della Notte, nel suo apparente trionfo, si abbandona per la prima volta nel dramma alla coloratura, come per una necessità interiore. Qui, la coloratura è davvero un mezzo espressivo, davvero necessario e capace di alleviare la tensione.
Il terzo atto ha un effetto irregolare; ciò deriva dall’accumulo di risoluzioni necessarie. Come accade raramente nella letteratura drammatica, troviamo qui nuovi personaggi (Aurora e Febo), significativamente coinvolti nella continuazione e risoluzione dei conflitti, che compaiono solo nel terzo atto. Il terzo atto, naturalmente, deve contenere principalmente motivi mozartiani. La citazione di Mozart è in parte richiesta dalle note di Goethe. Così, Aurora entra con la musica del glockenspiel da “Il flauto magico”. Non c’è bisogno di giustificazioni; poiché qui non si potevano udire altre note se non quelle di Mozart. Nei singoli numeri, Goepfart utilizza la forma musicale del rondò, che Mozart impiegava frequentemente. Doveva rimanere all’interno dello stile. Non si dovrebbe dire che si sia semplificato le cose citando la musica di Mozart. Al contrario, era un’enorme difficoltà adattare la propria sensibilità allo stile e allo spirito di Mozart per non far crollare l’intera opera. Avrebbe potuto sostituire le citazioni con la sua invenzione. Ma giustamente riteneva che l’espressione di Mozart fosse l’unica possibile in quei particolari passaggi.
La prima scena ci riporta ai popoli primitivi della foresta. Qui, Aurora libera Febo e restituisce così all’umanità il dono prometeico degli dei. L’azione culmina in una scena d’amore molto intima tra le due figure simboliche. Segue una scena burlesca, una sorta di panfest, adornata da una musica da balletto affascinante e distintiva.
La prima metamorfosi ci mostra uno spaccato di vita di corte nel palazzo reale di Tamino. Dame e gentiluomini litigano sulle ultime notizie. L’infruttuosa discussione si conclude con l’annuncio dell’ultima novità: l’ingresso del principe redento Febo con Aurora. Così inizia l’inizio della fine. Nasce una nuova era. Goepfart ha trovato toni deliziosi per la conversazione tra i cortigiani, toni che lo rivelano un maestro dell’umorismo musicale.
Una trasformazione aperta conduce al finale. Qui, i contrasti più sorprendenti emergono tra la gioiosa giubilazione per l’ingresso della giovane coppia principesca e il dolore dei sacerdoti per la morte di Sarastro. Queste due scene potevano essere rappresentate solo con motivi influenzati da Mozart, con il coro giubilante del finale del Flauto Magico e con la Musica di Fuoco e Acqua in Do minore. Con il progredire dell’azione, come con l’arrivo della Regina della Notte, che appare anch’essa per celebrare la vittoria e il giubilo, Goepfart ha trovato i suoi accenti personali, molto caratteristici. L’azione si trasforma in una catastrofe. La Regina chiede di vedere il suo nemico morto: “E se il mio regno cadesse in rovina!”. Tamino la conduce al sarcofago di Sarastro. Quando riconosce il viandante nel cadavere, crolla priva di sensi. Nel frattempo, “O Iside e Osiride”, nell’immortale melodia di Mozart, risuona da tutti i sacerdoti all’unisono, giurando di continuare a operare nello spirito di Sarastro anche dopo la sua morte. Sopraffatta dalla terribile consapevolezza (della propria sconfitta) che l’ha colpita, la regina esprime un appassionato desiderio di entrare nel sublime vincolo dell’amore, ma viene respinta con sdegno dai sacerdoti. Nella sua angoscia, la regina invoca il trasfigurato Sarastro (suo nemico e amico) affinché le dia un segno della sua riconciliazione e dell’adempimento del suo desiderio. Accade. Un genio appare, tocca la regina con la palma della pace e la conduce nel regno della pace eterna. Sarastro e la regina appaiono uniti nella cupola: l’amore ha vinto l’odio. Con esso, ogni male è sradicato. La famiglia regnante e il popolo ora si uniscono al coro giubilante della liberazione attraverso l’amore con un senso di euforia completamente diverso.
“Sarastro” di Goepfart-Stommel si rivela un’opera di intenti etici e di pura, grande volontà. Che la capacità di tenere il passo con la volontà sia innegabilmente evidente nella poesia e nella musica. I teatri d’opera tedeschi devono garantire che un’opera così seria e splendidamente realizzata non manchi di successo. È loro responsabilità dare risalto a un’opera che, nella sua nobile idea, nella semplicità e nella potenza della sua concezione e della sua esecuzione, si distingua dalla media, un’opera che, per la sua intrinseca semplicità e verità, occupa una posizione eccezionale nella creazione contemporanea e che – ne sono fermamente convinto – lascerà sempre un’impressione profonda e duratura. Il palcoscenico tedesco, che inizia con “Sarastro” di Goepfart, avrà la reputazione di un autentico capolavoro artistico.